Certezze e illusioni del "perché": il paradigma meccanicistico.
Covid-19 ha messo in crisi una parola a cui siamo molto affezionati: certezza. Una parola che però aveva in sé trappole e illusioni, con origini e radici ben salde.
La realtà di oggi è molto diversa da quella di inizio marzo, momento in cui ho finito di scrivere questo articolo, pianificando di pubblicarlo in questi giorni. In questi stessi giorni però l’ho riscritto, quasi tutto. Così come si sta riscrivendo anche tutto il resto, attorno a noi.
Sono le 17.48 di domenica 22 Marzo, 2020. Siamo ancora in piena crisi sanitaria da Covid-19. Scrivo dal divano, dove ho passato buona parte del pomeriggio. Il divano della mia casa di Como, una Como silenziosa, di quel silenzio rispettoso che solo la preoccupazione sa dare. Sembra che tutti qui stiano pensando, silenziosamente. E anche un po’ pregando, sperando, desiderando che le domeniche tornino ad essere quelle delle passeggiate e dei gelati. E anche dei bambini che urlano sotto casa quando tu, invece, vorresti tanto fare il tuo riposino.
Sono desideri borghesi, lo so. Ed è per questo che ho deciso di mettermi a scrivere, anzi a ri-scrivere questo articolo, per capire come trasformare questi desideri - che sono anche un po’ paure - in qualcosa di utile per me stessa e per altri, mi auguro.
Ve lo confesso: sono lontana dalla mia famiglia e sono preoccupata. Stanno bene, per fortuna, ma in questi giorni sto provando sulla mia pelle che ogni concetto che cerco di trasmettere in ambito organizzativo quando parlo di gestione delle emozioni, anticipazione di scenari, valutazione degli errori e di precisione nell’esercizio del ruolo… beh, diventa tremendamente difficile quando la posta in gioco è così alta e così personale.
Eppure, nemmeno per un secondo ho pensato che allora, se è così difficile applicarli, forse non sono concetti validi. Anzi: ripeto ogni giorno a me stessa che devo restare lucida per usare questa dolorosa situazione come occasione di crescita, di coesione e di responsabilità, individuale e di comunità.
Quali domande ci faremo e quali risposte saremo in grado di darci?
Perché sta accadendo tutto ciò? Perché non siamo ancora in grado di tornare alla normalità? Perché non ci dicono i dati corretti? Perché non riusciamo ad averli, questi dati? Perché proprio ora? Perché non stanno tutti a casa? E così via.
Proprio alla facilità con cui ci chiediamo “perché” avevo deciso di dedicare questo primo articolo della serie Paradigmi che incorniciano parole. E a maggior ragione oggi lo riprendo in mano perché è proprio sulla genesi delle parole e delle metafore del nostro linguaggio che posso e voglio dare un contributo. In fin dei conti, di questo mi occupo nelle aziende, del linguaggio che le persone usano in relazione ai loro percorsi professionali - che solo professionali però non sono mai. Soprattutto quando si fanno incerti.
L’incertezza non piace a nessuno.
Sappiamo però che c’è e infatti cerchiamo di difenderci: pianifichiamo, facciamo previsioni, test, regole, norme, leggi.
La scienza stessa ci ha allevato così, rassicurandoci sul fatto che la realtà aveva una spiegazione e, soprattutto, che non sarebbe mai cambiata.
Eppure, l’incertezza torna, tanto che persino la scienza si è dovuta arrendere fino a farne un principio (ma questo lo vedremo nello sviluppo dei prossimi articoli). Noi no, il nostro senso comune è molto più lento e non è nemmeno detto che riuscirà a farne un concetto proprio.
Da dove nasce il desiderio di prevedere e controllare le cose?
La scienza ha intrattenuto da sempre rapporti con quello che si definisce senso comune. Essa ne ha ritagliato il territorio. Il senso comune, il sentire popolare, i modi della sensibilità quotidiana risultano assoggettati, a partire dal XVII secolo, al potere delle teorie scientifico filosofiche che promuovono la nuova scienza. È la grande scienza meccanicistica che ordina e codifica l'opinione comune e che al tempo stesso penalizza i modi erronei, illusori della sensibilità percettiva. Tutti gli oggetti e tutti i termini prima di costituire il senso comune sono i relitti di un altro sapere anteriore, recitato e respinto.
Aldo Gargani aveva già detto tutto: è una questione di disequilibrio e assoggettamento del senso comune alla scienza.
Il paradigma meccanicistico ha plasmato la nostra cultura e sotto certi aspetti continua a farlo: Copernico, Galileo e Newton (ma volendo, possiamo andare indietro nel tempo fino a Cartesio) hanno completamente rivoluzionato il modo di guardare il mondo raffigurandolo come una macchina con regole ben precise, da scoprire, spiegare e possibilmente prevedere.
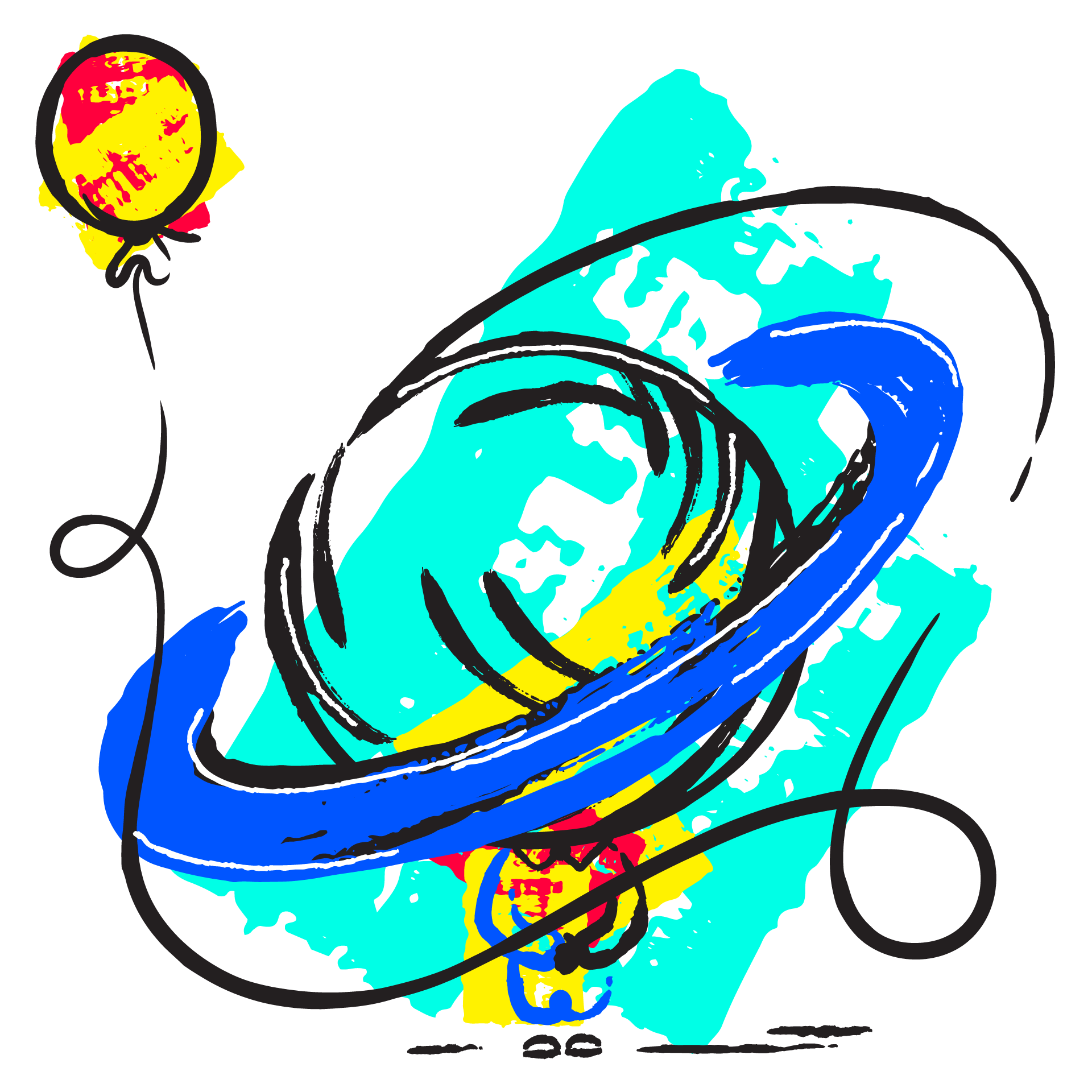
La danza tra senso comune e senso scientifico inizia infatti proprio con la rivoluzione copernicana, quando l'osservazione scientifica offre prova del fatto che ciò che percepiamo con i nostri sensi può essere un inganno. Ma pur capendo questo e avendo quindi iniziato a distanziare il senso comune dal senso scientifico, i due sensi rimangono molto vicini nel modo di concepire la realtà: per entrambi le cose esistono (sembra banale e scontato, ma vedremo che non lo è) ed entrambi vogliono poterle "fotografare", descrivere e spiegare con leggi di causa-effetto.
Mi spiego meglio: il discorso scientifico di tipo meccanicistico è basato sul formulare Leggi (es: Legge di Newton) e trovare cause. Di pari passo nel senso comune si depositano e si rafforzano formule linguistiche, repertori, discorsi e significati che rimandano a nessi causali tra gli eventi (non necessariamente quelli naturali, anche quelli sociali, psicologici, umani in generale).
Questa è un’illusione che nel tempo la scienza ha imparato a gestire. Mentre noi no. Parafrasando Carlo Rovelli, siamo ancora convinti che la realtà sia come ci appare. E l’unico strumento di “potere” che abbiamo nei suoi confronti è quello di riuscire a darne una spiegazione. Ci serve per stare tranquilli, sapere dove andare e pensare che andrà come vogliamo noi. Le regole, le procedure e le gerarchie servono a soddisfare questo bisogno innato di ordine, di governo e di certezza. E quando succede qualcosa che non avevamo previsto (succede sempre, a livello più o meno drammatico) ci manca la terrà sotto i piedi.
Quali sono i discorsi possibili, se la cornice è quella della legge causale?
Qui la questione è delicata e cerco di condividere un pensiero che in questi giorni si è fatto più forte in me. La parola legge ha una sua propria dimensione semantica: una legge infatti consente, disciplina, impone, obbliga, prescrive, prevede, proibisce, punisce, regola, sancisce, sanziona, stabilisce, vieta… e così via. A seconda dei momenti può essere percepita come equa, ingiusta, ferrea, inflessibile, naturale e universale. Una Legge è totalizzante, mai parziale.
La parola legge dunque incornicia tutti quei discorsi normativi che permettono di determinare gli eventi e di governarli:
- “è per forza così”
- “non c’è altra soluzione”
- “questo cambia tutto”
- "è evidente che”
- "non è possibile che”
- “si può/non si può fare”
Queste sono le parole che un paradigma di tipo meccanicistico ci rende disponibili. Sono formule linguistiche che usiamo per mettere dei punti fermi, quasi sempre per prescrivere, prevedere e giustificare una posizione o una scelta. Servono a darci delle regole quando la situazione attorno sembra avere molte variabili fuori controllo. Ma c’è anche un contro: le regole in qualche modo deresponsabilizzano le persone che le “subiscono”. O perché non le capiscono, o perché non le condividono o perché sono scomode. Sta di fatto che la regola serve, ma per essere efficace deve essere anche condivisa.
È sotto i nostri occhi in questi giorni di continue regole (necessarie) ma anche di altrettanti ammonimenti, denunce e inasprimenti.
Come se la regola non riuscisse ad imbrigliare la natura incerta delle interazioni umane.
L’unico strumento per farlo è proprio responsabilizzare ciascuno di noi, far sì che le nostre interazioni vadano verso un obiettivo comune: la salute della comunità (e non solo la propria, in ogni caso illusoria).
Lo vediamo anche in un certo modo di intendere le organizzazioni, figlio ancora di quella rivoluzione industriale che ha dato vita al cosiddetto management scientifico di Taylor:
- regole e meccanismi
- organizzazione gerarchico-burocratica
- esercizio di potere dall'alto (strategia top-down: interazione unidirezionale)
- sistemi di controllo e predizione
- punizione degli errori o premio per i più produttivi
Con le note ricadute in termini di scarsa soddisfazione delle persone, poco coinvolgimento nel progetto imprenditoriale, bassa produttività; quando nelle intenzioni l’obiettivo sarebbe esattamente l’opposto. Infatti, questo tipo di organizzazione - di vecchio stampo forse, ma ancora molto, molto presente nei nostri discorsi - ha come obiettivo primario proprio quello di lavorare solo sull’efficacia: perfezionare la macchina per produrre di più. E più si produce, meno si coinvolge, sembrano dirci i fatti.
In questa cornice nascono tutti i sistemi di misurazione delle performance basati sulla produttività e sulla quantità di prodotto o servizio erogato. In questa cornice nascono anche tutti quei discorsi sentiti in modo disordinato in questi giorni, dal “non possiamo fermare tutta la produzione” al “non ci sentiamo tutelati, quindi fermiamo la produzione”.
Bianco o nero?
Due visioni, da una parte e dall’altra dello stesso campo da gioco, che ci danno conto di come comunque le regole - da sole - non permettano di inglobare le esigenze di tutti gli attori coinvolti. Se qualcosa possiamo imparare dalle restrizioni che l’Italia sta attuando in queste settimane, è che sono certamente necessarie in un momento di emergenza sanitaria, ma non sono sufficienti (se non controproducenti) per generare una comunità in salute, basata sulla responsabilità di ognuno. Così come, con ricadute molto meno drammatiche, i modelli organizzativi di tipo gerarchico non portano alla partecipazione e al coinvolgimento delle persone nelle nostre aziende.
E attenzione, perché se ristrutturiamo il modello senza lavorare in profondità sul senso e sulla genesi delle parole che utilizziamo, in realtà non stiamo ristrutturando proprio nulla.
Facciamo allora il primo passo ripensando alle nostre organizzazioni, a partire dai discorsi che riconfigurano il lavoro e i nostri percorsi professionali e imprenditoriali: alla luce di un’incertezza sempre presente ma, ci auguriamo, meno dolorosa di oggi, quali domande è utile farsi?

Condividi

Lascia il tuo commento
Grazie!
Il tuo commento sarà visibile a tutti tra qualche minuto.
Ouch...
Qualcosa è andato storto. Per favore segnala il malfunzionamento a annagirardi@mail.com