Ipotesi e pensiero corto: pro e contro del paradigma relativistico.
Le ipotesi sul futuro sono utili, a patto di non considerarle future certezze.
Il problema del fare ipotesi è che poi ci aspettiamo che almeno una di queste diventi realtà. La relazione tra realtà e ipotesi, però, è molto più complessa di così.
Le ipotesi abbiamo iniziato a farle da poco più di un secolo; nei confronti delle ipotesi, insomma, siamo ancora dei praticanti.
Nella scorsa puntata ci siamo lasciati esaminando la storia del pensiero comune in relazione allo sviluppo del pensiero scientifico, dal XVII secolo in avanti: un tripudio di leggi, regole, previsioni e spiegazioni. In questo siamo ancora molto bravi, nonostante poi nel frattempo il pensiero scientifico sia andato avanti.
Lo vediamo anche oggi, che ci ritroviamo a fare tante ipotesi sul futuro, nel tentativo di ridurre - almeno un po’ - l’incertezza in cui ci siamo trovati ad abitare. Stiamo facendo confusione però:
l’incertezza non è l’assenza di conoscenza.
Nuovi discorsi, vecchie parole.
Piccola digressione: la questione linguistica porta con sé un intricato rapporto con il nostro percepire le cose; per questo cerco di raccontarla tirando dentro alla storia chi di percezione se ne intende: il senso scientifico. Da lui possiamo imparare il profondo legame tra domande e risposte. Un legame quanto mai di rilievo oggi che dobbiamo imparare a farci buone domande, proprio perché abbiamo sempre meno risposte.
Questa rubrica era nata nella mia testa prima dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di usare un po' di filosofia della scienza e di filosofia del linguaggio al servizio del tanto desiderato cambiamento nel mondo delle organizzazioni.
Un cambiamento in meglio, per il business e per il benessere delle persone, oggi più necessario che mai, dato che business e benessere sono messi a dura prova da… sappiamo tutti cosa.
Questo cambiamento oggi riguarda tutti e non solo le organizzazioni aziendali. Finora però è un cambiamento vero solo a metà: nelle intenzioni sicuramente, un po' meno nelle parole; ancora quelle vecchie parole che sanno tanto di determinismo.
Cerchiamo nuove regole di mercato, di pensiero, di normalità (che, per quanto “nuove”, sono sempre regole), facciamo previsioni ("quando tutto riaprirà") e ci diamo qualche spiegazione (“non potrà più essere come prima perché….”). Parole più o meno rassicuranti che ci servono per rimanere aggrappati all’unica realtà che conosciamo, anche se non sappiamo più come è fatta.
Insomma, rischiamo di fare un grande sforzo verso un futuro diverso da quello di oggi, senza portarci dietro le parole giuste. Uno sforzo a vuoto dunque.
Una grande prova per il senso comune!
Vogliamo capire cosa sta accadendo e soprattutto cosa accadrà ma, come ha scritto Luca Sofri:
Il problema principale nella comprensione delle cose è la nostra incapacità di accettare la complessità, il “dipende”, l’incertezza.
[spoiler: i “dipende” sono cosa diversa dall’incertezza]
L’incertezza non piace a nessuno: siamo abituati a risposte e soluzioni certe. Il senso comune ragiona così e continua a farlo anche quando la “cosa” su cui ragionare è l’incertezza stessa. Se ci pensate però, questo è quasi un paradosso: parliamo dell’incertezza come se così riuscissimo a capirla meglio, come se riuscissimo a metterla più a fuoco. Ma se potessimo davvero farlo, smetterebbe di tale, no?
La notizia però è che l’incertezza esisteva prima ed esisterà anche dopo.
Il senso scientifico questa cosa l’ha capita, per gradi e non senza dissidi interiori. Ha capito soprattutto che "incertezza" non vuol dire "mancanza di conoscenza" e che, anzi, possiamo essere molto certi delle cose che conosciamo (non che sappiamo), senza eliminare l’incertezza di fondo.
Per arrivare a capirlo ha fatto un lungo viaggio, di cui oggi vi racconto la seconda tappa: quella che per la prima volta ha introdotto la parola “dipende” nelle nostre granitiche certezze.
Le leggi universali del mondo non spiegano più il mondo.
Nella prima tappa, ci eravamo lasciati alla fine del XVII secolo, con un paradigma meccanicistico che rafforza il modo di ragionare già proprio del senso comune: cause-effetti-spiegazioni-previsioni. Un senso comune dunque che - nella sua estrema necessità di trovare una spiegazione alle cose - ben accoglie i dettami di quel paradigma; salvo poi trovarsi inerme di fronte a due variabili potenzialmente esplosive:
- una situazione complessa da risolvere
- una comunità intera da responsabilizzare e coinvolgere.
In questi casi servirà una rivoluzione, ma per arrivarci (ci arriveremo) dobbiamo passare da questa tappa intermedia - anche se tanto intermedia non è, visto che stiamo parlando delle due teorie che hanno stravolto il nostro modo di relazionarci con il mondo.
È l’inizio del XX secolo, 1905 e Einstein pubblica la sua teoria della relatività ristretta; qualche anno dopo, nel 1916, pubblica anche la teoria della relatività generale e rivoluziona completamente tutti i concetti della fisica classica: spazio, tempo, velocità, accelerazione, massa.
Il primo passaggio importante per noi è che le leggi generali, così come il paradigma meccanicistico ce le aveva raccontate, non spiegano più il mondo.
Il secondo passaggio importante è che questo mondo non può più essere unico e assoluto, proprio perché esistono dei sistemi di riferimento.
Di realtà non si può più parlare, perché ogni realtà diventa relativa al modo di osservarla.
Una rivoluzione scientifica, epistemologica e filosofica: la realtà diventa realismo, ipotetico per di più.
Dal paradigma meccanicistico a quello relativistico.
I discorsi del senso scientifico cambiano: il concetto di causa inizia a vacillare, in favore di quello di probabilità; e la Legge universale viene sostituita da Teorie.
[è la seconda volta in poche righe che scrivo questa parola in grassetto. E infatti è una parola importante, tra poco vedremo perché].
Teorie che fanno ipotesi sul mondo e di quel mondo ci restituiscono una visione molto precisa, ma pur sempre parziale. Anzi, relativa. La distanza tra senso comune e senso scientifico si fa così più ampia:
- il senso comune percepisce che le cose stanno così come le vede;
- il senso scientifico osserva che le cose stanno in base alla teoria che usa.
Il senso scientifico continua però nel suo percorso di conoscenza e piano piano ci educa verso una nuova percezione delle cose.
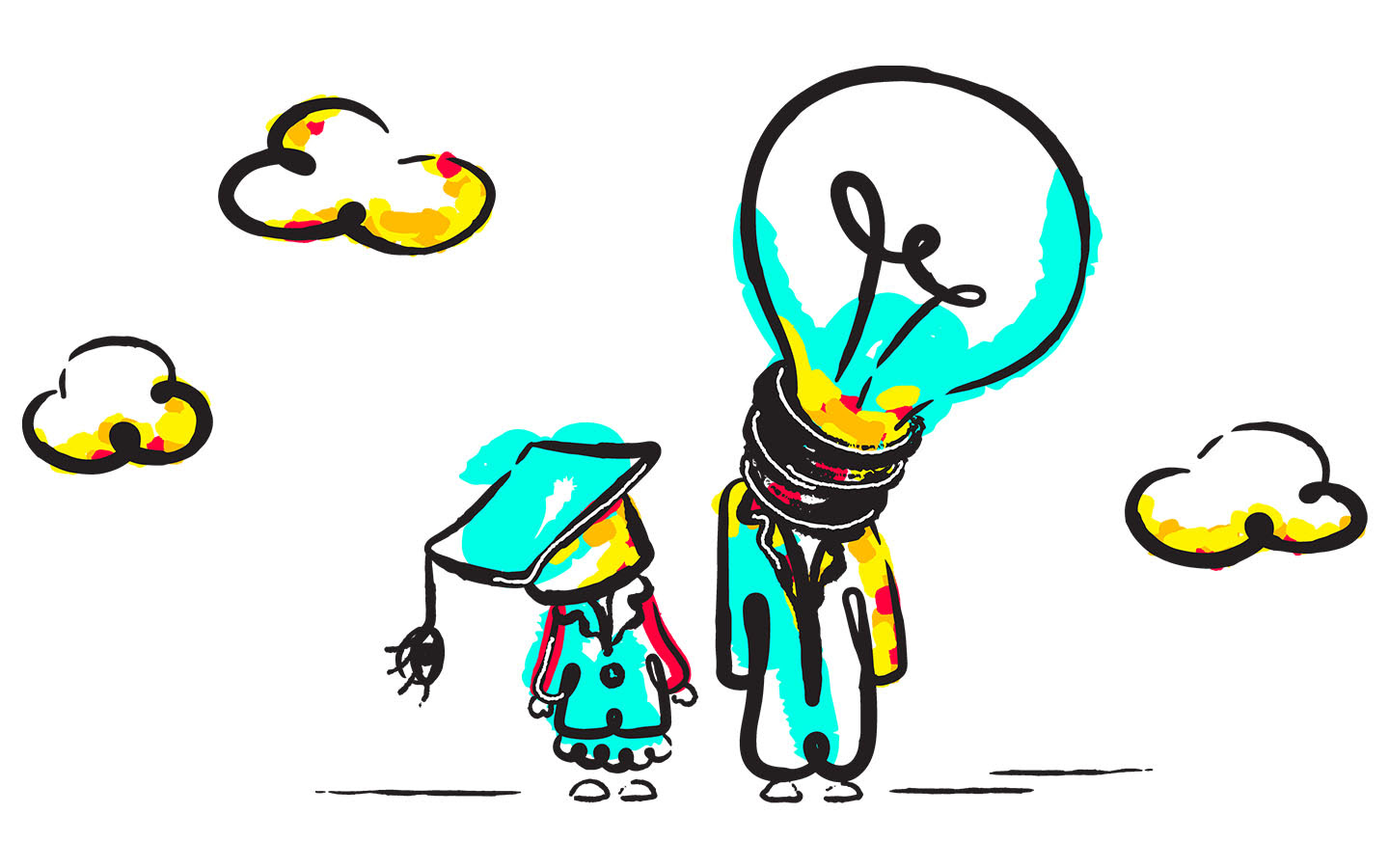
A modo nostro, grazie alla forza retorica del linguaggio, iniziamo a familiarizzare con la relatività: del proprio punto di vista almeno si può esser certi!
La rivoluzione è anche discorsiva.
La rivoluzione scientifica e filosofica della relatività ne porta con sé un’altra: irrompe nello spazio discorsivo la parola teoria. Una parola rivoluzionaria proprio perché spazza via l’illusione dell’assoluto e spalanca le porte al ragionamento, al confronto e alla discussione di ipotesi diverse.
Una teoria infatti può convincere, essere adeguata, attendibile, credibile o debole; si può discutere, dimostrare, costruire, rivedere, scartare, argomentare, accettare o rifiutare. Abbiamo iniziato a dire:
- “dipende dal punto di vista” e non più solo “è per forza così”
- “non è come sembra” e non più solo “non c’è altra soluzione”
- “potrebbe essere che” e non più solo “è evidente che”
- “secondo me”
- “tu come la vedi?”
Formule linguistiche che usiamo per discutere, analizzare, valutare, confrontare e proporre. Oggi sembra scontato, ma i nostri “dipende” prima di Einstein non erano nemmeno pensabili.
Nuovi discorsi, nuovi modelli organizzativi.
Pensare in termini relativi cambia non solo il nostro modo di parlare ma anche quello di organizzare le cose: le sezioniamo, le dividiamo in pezzi e creiamo reparti o canali specifici a cui affidiamo una parte del tutto.
I modelli organizzativi di tipo funzionale fanno appello proprio a questo principio di parcellizzazione della realtà, forti del fatto che ridurre in parti un sistema complesso possa aiutare a gestirlo con maggiore efficacia ed efficienza.
Anche il linguaggio organizzativo si è adeguato:
- non più regole ma procedure
- non più gerarchia ma specializzazione
- non più potere unidirezionale ma distribuito
- non più controllo ma consenso democratico
Quasi sempre però l'effetto negativo è che l'obiettivo generale si frammenta e serve un grande sforzo per tenere insieme i pezzi. E l'efficienza diventa presto inefficienza.
Una ragione di questa disfunzione la si può trovare proprio nelle differenti modalità linguistiche e interattive che le persone adottano a seconda del grado di responsabilità che hanno.
A livello discorsivo, infatti, l’organizzazione funzionale si spacca in due:
- i responsabili, per gestire il team e allinearsi con le altre funzioni d’area, devono (dovrebbero) adottare modalità aperte al dialogo: valutazione, proposta e confronto;
- gli operativi, che per ruolo devono eseguire e non discutere, rimangono su modalità più chiuse, con il rischio di una maggiore delegittimazione e di contrapposizione con i responsabili.
Esattamente come nell’organizzazione gerarchica, diventa quasi impossibile far partecipare e coinvolgere le persone. Al massimo si può ottenere adesione. Così, pur avendo un modello diverso, il paradigma non cambia: dentro ogni reparto, l’unica strategia di governo è il controllo ottenuto tramite premi e punizioni.
Non vi suona familiare?
Covid-19 e il pensiero corto.
Se invece di pensare alle sole organizzazioni aziendali, pensiamo all’organizzazione della comunità oggi, salta all'occhio il medesimo schema:
- diversi punti di osservazione (sanità, lavoro, economia, famiglia: tutto frammentato per affrontare il problema un pezzo alla volta);
- cittadini schierati tra chi si adegua e chi no;
- un sistema di punizione per chi non si adegua.
Questa è la via che abbiamo trovato partendo da una forte percezione di pericolo e da ipotesi traballanti.
Ipotizzare l’intervento sanitario e la restrizione degli spostamenti come unica via di governo dell’emergenza ha creato infatti l’aspettativa che con queste due soluzioni la realtà sarebbe tornata come prima. Forse al contempo avremmo dovuto educare le persone (soprattutto attraverso le parole) a capire la differenza tra distanziamento sociale e distanziamento fisico, a capire che non siamo in guerra e che in generale una comunità in salute è ben più che una comunità sana.
Avremmo dovuto sì, ma purtroppo non potevamo perché la teoria che abbiamo usato in partenza era parziale e ci ha fatto vedere solo un pezzo del problema.
Nuovi discorsi, nuove parole.
Ridurre la complessità in pezzi non va mai bene, nemmeno quando ti illudi di preservarla facendo pezzi grandi.
Ridurre la complessità va ancora peggio in situazioni di emergenza, perché porta ad affrontare con miope urgenza i problemi che man mano si presentano:
- il problema è sanitario, faccio un ospedale
- il problema è la vicinanza fisica, distanzio le persone
- il problema è ancora la vicinanza fisica, chiudo le aziende
- il problema è economico, do liquidità
… e così via, fino a che non diventa d'obbligo ricomporre il puzzle, dovendosi accontentare di risposte parziali e con il pensiero piuttosto corto.
Tutto ciò avviene perché il nostro senso comune ha tradotto la relatività in segmentazione, facendo del punto di vista la stessa cosa che prima era la legge assoluta: un dato di fatto.
Oggi più che mai invece abbiamo bisogno di educarci all’incertezza, che purtroppo non si affronta a suon di ipotesi verosimili, sperando che poi diventino realtà. L’unica possibilità è nell'interazione: quella nuova che dovremo costruire tra le persone; ma soprattutto quella che esiste tra il nostro modo di concepire la realtà e ciò che la realtà, così, diventa.
Più semplice: possiamo smettere di fare ipotesi su "come sarà" e concentrarci piuttosto su "come vogliamo che sia". Questo non ci metterà al riparo dall’incertezza, ma ci renderà padroni delle scelte che di volta in volta faremo.
L'interazione è la lezione più preziosa che dovremmo portarci a casa da questa emergenza.
L’interazione è ciò che ci consente di stare nell’incertezza, non di evitarla né di ridurla.
L'interazione è il principio alla base oggi del senso scientifico.
Interazione è la nuova parola a cui sarà dedicato l’ultimo capitolo di questa piccola serie.
Alla prossima.

Condividi
