Perché siamo tutti un po' virologi (e anche un po' psicologi)?
Non facciamo che parlare del virus e delle conseguenze psicologiche della quarantena. È normale, ma c'è di più.
Avete notato che nell'ultimo mese siamo diventati tutti un po' più esperti di virologia? È normale: siamo bombardati di notizie sul virus, leggiamo tanto, ascoltiamo le opinioni dei virologi; ne parliamo con gli amici e cerchiamo di farci un'idea. Poi la confrontiamo con quella degli altri, prendiamo i dati e diciamo la nostra.
È normale: più una cosa ci riguarda da vicino, più informazioni circolano e più noi diventiamo un po' esperti di quella cosa. Il Covid-19 in questo momento. Lo stesso succede per tutti gli effetti psicologici che quella cosa ha su di noi. Quindi, dibattiamo molto anche sulla quarantena e su come affrontarla: rimanere produttivi o concederci il tempo che non abbiamo mai avuto? Non fermarci o approfittare del momento per stare di più con noi stessi? Capire cosa conta veramente o cavalcare l'onda per inventarci qualcosa di nuovo? Insomma, gli schieramenti sono chiari e ognuno dice giustamente la sua per affrontare questo momento.
In fondo, un po' psicologici lo siamo sempre stati tutti, ma in questi giorni ancor di più. Perché?
Ecco, oggi esco un po’ dal seminato delle parole del lavoro e mi faccio trasportare da questo perché.
Oggi vi parlo delle parole esperte e di quelle non esperte che in questi giorni affollano i social, i giornali, le newsletter e le telefonate con parenti e amici.
Oggi è sabato 4 aprile 2020, il primo sabato di una quarantena che avrebbe dovuto terminare ieri e invece no; abbiamo bisogno di più tempo ed è giusto che sia così, perché così vanno le cose: si testa, si sperimenta e poi si ripianifica in base ai dati raccolti.
E a proposito di dati - una cosa che di solito associamo a qualcosa di certo, sicuro, univoco - vi sarà capitato di leggere qualche articolo per capire che, beh, questi dati sono quantomeno imprecisi. C'è malafede dunque dietro ai dati? Ci stanno nascondendo qualcosa? Io non lo so, ma non lo credo. Credo piuttosto si tratti di fretta, a volte di incompetenza e di sicuro di un eccesso di senso comune. Un senso comune che pervade anche gli uomini di scienza quando non stanno bene attenti ai confini della loro disciplina e al modo con cui cercano di farsi capire dai non esperti (cioè noi).
A ben vedere, la confusione che ruota attorno ai dati assomiglia un po' a quella che ruota attorno alle diverse opinioni degli esperti virologi che di giorno in giorno scandiscono le nostre giornate. In una situazione così fluida dunque è piuttosto normale che ognuno di noi cerchi di trovare ordine e di partecipare in qualche modo alla costruzione di una realtà un po' meno incerta di come l'ha trovata.
Siamo preoccupati e questa è già una buona ragione per farlo. Io stessa, che di solito mi tengo alla larga dal dare opinioni su cose che non conosco bene, ho ceduto e ho fatto le mie ipotesi, anche se di virologia non so praticamente nulla.

Nulla, se non che studia le caratteristiche biologiche e molecolari dei virus. So poi che per quanto riguarda noi essere umani, c'è la virologia medica, che studia i virus coinvolti nelle malattie dell’uomo. So qualcosa di più di biologia, perché era una delle mie materie preferite al liceo e perché poi ho voluto e dovuto studiarla nel mio percorso di laurea in neuroscienze. Ma di certo non ne so abbastanza da potermi esprimere su cosa funziona e cosa no per affrontare un’emergenza sanitaria.
Eppure anche io in questi giorni ho detto la mia. In privato, al tavolo della colazione, al telefono con gli amici e in qualche riga scritta pubblicamente.
Perché?
A questa domanda mi do due ordini di risposte:
- la prima è di carattere comune, se volete “umano”: di punto in bianco la nostra salute fisica e quella dei nostri cari è in pericolo, perciò tutto il resto passa in secondo piano. Di questo dobbiamo parlare;
- la seconda invece è di carattere scientifico.
Ecco, su questo mi sento sufficientemente preparata per poter dire una cosa che a qualcuno potrà suonare dissonante.
Biologia, virologia, fisiologia, psicologia, sociologia o antropologia condividono, pur nella loro specificità, il fatto di essere scienze discorsive. Quel suffisso -logos le accomuna tutte e le rende più vicine al senso comune di quanto non siano invece quelle scienze che hanno formalizzato il loro linguaggio (la matematica, per esempio).
Le scienze discorsive conoscono attraverso il linguaggio ordinario e questo le espone all’opinionismo dilagante del senso comune.
Questo non vuol dire certo che allora sono poco “scientifiche”; vuol dire però che devono stare bene attente a rispettare quei criteri di scientificità che fanno sì che i loro discorsi siano annoverati come scientifici (appunto).
Virologia e psicologia sono scienze discorsive.
E parlano, in qualche modo, con le nostre stesse parole. Questo le accomuna: entrambe producono conoscenza attraverso discorsi su qualcosa (il vīrus o la psiche): usano il linguaggio ordinario, lo stesso di tutti noi comunità di parlanti. Se ricordate - ve ne ho parlato qui - il linguaggio ordinario ha una caratteristica: ciò che viene detto assume valore in funzione dell'uso stesso del linguaggio.
Questa è anche la cosa che, oltre ad accomunarle, permettere di distinguerle in diverse "categorie", in base a come definiscono il proprio oggetto di indagine. Nello specifico:
- la biologia (e tutti suoi derivati, virologia compresa) circoscrive, nomina e definisce dei concetti. Questo vuol dire due cose: la prima è che tra tutti i significati possibili di una parola ne sceglie (o ne dà) uno e uno soltanto; la seconda è che quel significato è valido entro tutto il confine della biologia. Per capirci: tutti i biologi e virologi concordano su questa definizione:
un "virus" è un'entità biologica con caratteristiche di parassita obbligato, in quanto si replica esclusivamente all'interno delle cellule di altri organismi.
Mi fermo qui perché, appunto, non è il mio campo ma è sufficiente per dire che questa è la definizione condivisa in virologia, pur non essendo ovviamente l'unica disponibile nel vocabolario, a seconda dei campi di studio o interesse.
- la psicologia invece ha a che fare con costrutti. Questo vuol dire che, sì, anche l'oggetto di studio della psicologia ha una propria definizione ma con la sostanziale differenza di variare in base alla teoria di riferimento. Le teorie psicologiche sono infatti numerose e ognuna studia una cosa leggermente - ma radicalmente - diversa.
Tanto che c'è chi parla di "psiche", chi di "mente", chi di "comportamento" e così via.
Avere a che fare con dei concetti consente alla biologia di muoversi secondo questi due criteri:
- individua l’oggetto che vuole studiare
- lo misura
È la valenza denotativa del linguaggio che glielo permette - ne ho parlato sempre qui.
La stessa cosa non può fare la psicologia, per il semplice fatto che non ha nessun oggetto a disposizione, solo un'astrazione, una serie di ipotesi - costrutti per l’appunto - soggetti alla fluttuazione del linguaggio ordinario (nella sua valenza connotativa, che modella il significato delle parole a seconda del contesto e di molte altre variabili).
La psicologia per essere rigorosa deve quindi:
- dichiarare e argomentare in modo chiaro il costrutto (ciò di cui sta parlando)
- esplicitare i presupposti su cui basa quell’argomentazione
Cioè, deve sempre e comunque ricordarsi che sta parlando di un'ipotesi e mai di qualcosa di tangibile e afferrabile.
Ora non mi voglio però dilungare su come biologia e psicologia riescano ad essere più o meno scientifiche, ma solo dire che per esserlo devono seguire criteri diversi. Criteri che però nel senso comune fanno poca presa di fronte alla potenza retorica del linguaggio ordinario. Noi, non esperti, usiamo i termini di una lingua quasi sempre a livello del loro significato lessicale, stabilito nell’eloquio quotidiano in modo negoziale e interattivo. Vale a dire: a noi, comunità di parlanti, poco importa della definizione scientifica delle parole se, comunque, con la nostra riusciamo a costruirci sopra dei discorsi.
Ecco perché virologia e psicologia diventano facilmente parte di discorsi comuni.
A volte anche in modo un po' maldestro.
Invasioni di campo
E poi c’è un’altra cosa che accade, frutto dello stesso gioco a cui ci sottopone il linguaggio: così come noi non esperti possiamo dire la nostra su questioni che riguardano la biologia o la psicologia umana, anche tra esperti può esserci una sorta di invasione di campo.
Così non è raro ascoltare l'opinione di un virologo su come rimanere positivi e produttivi anche durante un’emergenza sanitaria e l'opinione di uno psicologo su alcune scelte sanitarie e sulla loro efficacia. In fondo, prima di essere scienziati, siamo persone ed è difficile separare le nostre sfaccettature in settori indipendenti l'uno dall'altro. Però questo può diventare un problema quando, da esperti, dobbiamo studiare un metodo di intervento sulla sanità (biologia) e sulla salute (psicologia).
Due cose diverse su cui non possiamo fare confusione, altrimenti rischiamo di essere inefficaci.
Se trattiamo i fenomeni psicologici alla stregua di fenomeni biologici e viceversa - quindi se riduciamo la salute della persona e della comunità ai soli aspetti sanitari - ci perdiamo per strada la possibilità di creare salute anche in un contesto di malattia, come quello che viviamo oggi.
E senza quasi accorgercene, per il nostro senso comune la restrizione sanitaria diventa anche una restrizione psicologica.
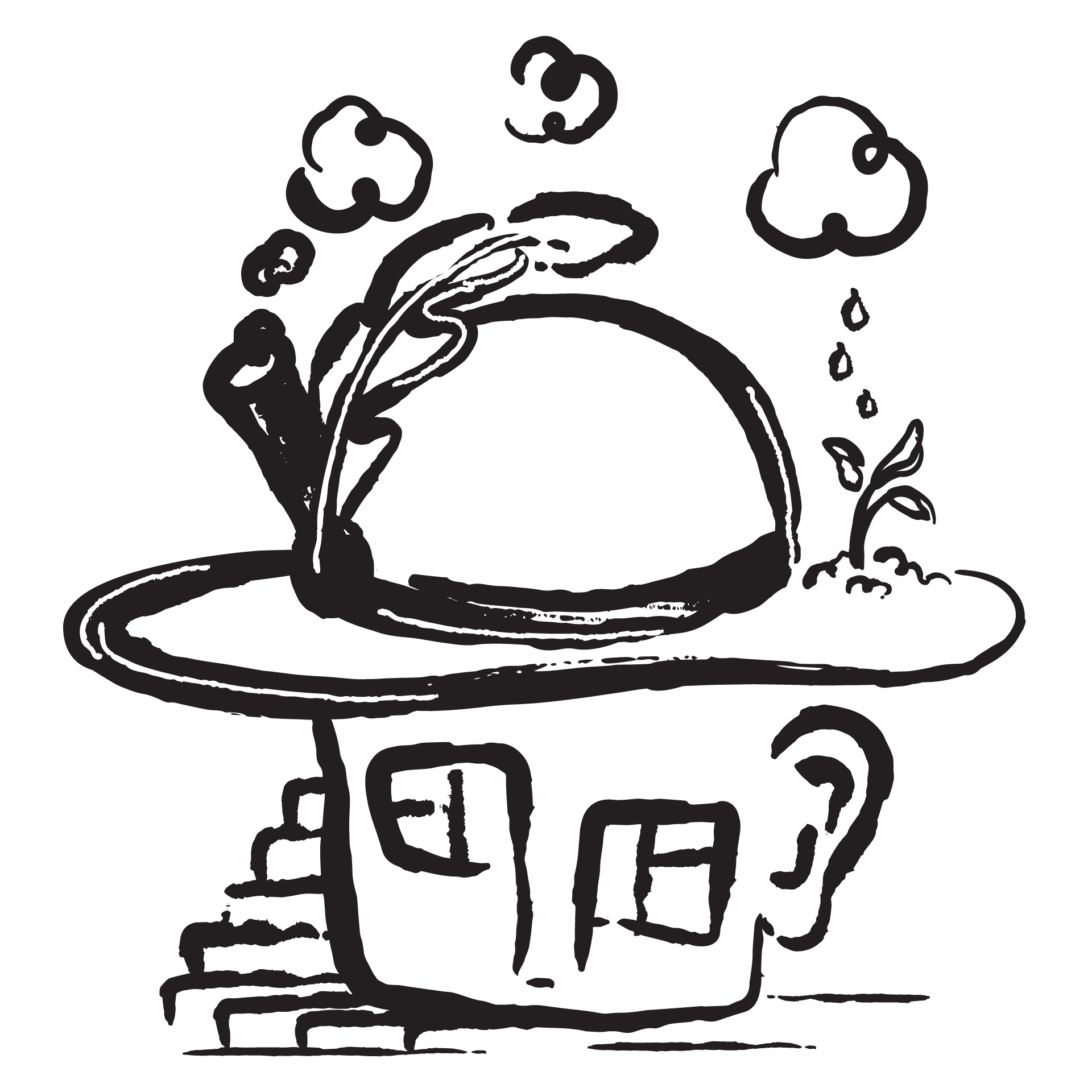
Il senso comune accoglie ciò che il senso scientifico gli offre.
Se da non esperti facciamo confusione e a volte ci mancano gli strumenti per fronteggiare questa situazione, è anche perché chi dovrebbe guidarci nella delicata distinzione tra sanità e salute, a volte non lo fa, vittima forse inconsapevole delle trappole del linguaggio ordinario.
E così diventiamo tutti un po’ biologici, in questo momento tristemente virologi e in fondo sempre un po’ psicologi.

Condividi
